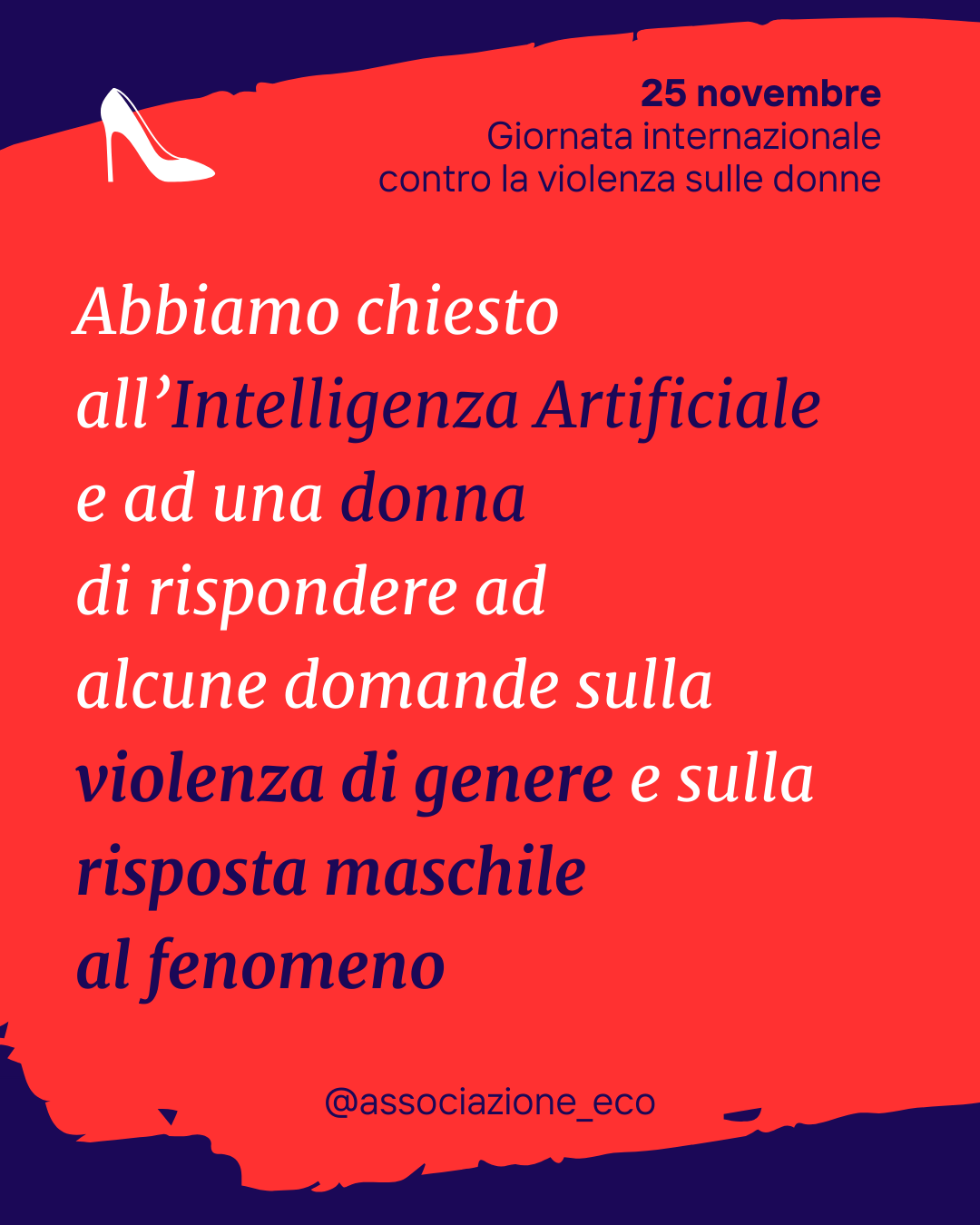“Dire omicidio ci dice solo che qualcuno è morto.
Dire femminicidio ci dice anche il perché”
Michela Murgia
Novembre 2023, 106 femminicidi.
Nel 2022 sono stati 126
nel 2021, 115 nel 2020, 128
nel 2019, 111
Si stima che almeno l’87% dei femminicidi sia commesso da un familiare, e la metà dal partner/ex.
E non ci sono solo le morti.
Le denunce per maltrattamenti sono passate dalle circa 9.700 del 2013 alle 19.900 di un 2023 che deve ancora finire.
Nello stesso decennio le denunce per atti persecutori è passata da circa 9.600 alle 13.800 di questi 11 mesi. E ricordiamoci che lo stalking è reato solo dal 2009.
Le violenze sessuali hanno registrato un incremento del 40,2% negli stessi dieci anni.
Numeri freddi e spaventosi che è bene sottolineare fanno riferimento ai soli casi denunciati, escludendo quindi quelli che sfuggono alla cronaca e tutto un sommerso che riguarda in particolare le donne più fragili come le migranti, le trans, le sex workers.
Il 25 novembre non deve parlare di donne, deve parlare di uomini. Agli uomini.
In un Paese nel quale continuano a diminuire gli omicidi, i femminicidi restano pressoché immutati e le violenze sulle donne aumentano. Questo spinge ad una riflessione obbligatoria ma ancora troppo ostracizzata: perché gli uomini uccidono le donne? Perché questa violenza sistemica che tocca trasversalmente donne di qualunque etnia, età, estrazione sociale? E’ una dinamica di potere che le vuole sottomesse. E’ PATRIARCATO.
Una parola “divisiva”, dice chi ha il privilegio di sedere dal lato dei carnefici.
“Not all men”, non tutti gli uomini, gli fanno coro altri, più preoccupati dal sentirsi (dirsi) innocenti che dal capire come recuperare una “dignità di genere” comprensibilmente e profondamente messa in discussione. Eppure nessun uomo è esonerato dal fare la propria parte per smantellare la società che lo privilegia tanto, a discapito di altri. È ora che gli uomini capiscano che possono piangere, chiedere aiuto, sentirsi fragili, che la cultura machista deve finire per la loro libertà e per la nostra sicurezza.
Gender pay gap, pinkwashing, mansplaining, catcalling, victim blaming, tone policing, un mondo di inglesismi che racconta una quotidianità fatta di differenze salariali, di molestie, di controllo economico, di uomini che zittiscono o che pretendono di spiegare alle donne per quali istanze che le riguardano dovrebbero combattere e come farlo. A voce bassa e senza disturbare troppo, grazie.
“Avete già ottenuto molto” “Un passo per volta” “Le priorità sono altre” “Gli uomini si sentono destabilizzati” “Vedete il patriarcato ovunque”
Si è addirittura coniato il termine “nazifemminismo” per dipingere le donne come invasate, violente e ottuse, come se poi si chiedesse di togliere qualcosa a qualcuno, e non di ottenere tuttə di più.
In un Paese con il 97% di CEO uomini, con una media del 13% di differenza salariale, sono sempre tavole rotonde di maschi bianchi cis etero che dettano le regole di un flebile diritto all’aborto, che osteggiano la diffusione di un italiano inclusivo tra schwa e professioni finalmente declinabili al femminile, svilendo la necessità di essere riconosciute anche per mezzo delle parole come se si trattasse di un capriccio, mentre le parole sono tutto ed è attraverso queste che esistiamo. Sono questi stessi uomini che vorrebbero decidere come intervenire per prevenire la piaga sociale che miete vittime con un cadenza media di una ogni 72 ore. Perché è di prevenzione che si deve parlare.
Di una pena più severa, una donna morta non sa che farsene.
Fonti:
Ministero dell’Interno, Wired, Osservatorio violenza sulle donne, Osservatorio nazione Non Una di Meno
Per approfondire:
Donata Columbro, giornalista, “femminista dei dati”
Ella Marcello, copywriter, insegnante, scrittrice, attivista
Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, scrittore
Mica Macho, community di sensibilizzazione contro la mascolinità tossica
Flavia Brevi, fondatrice e creativa di Hella Network ed esperta di comunicazione inclusiva
———————————————————————————————————————–
Intervista all’Intelligenza Artificiale su violenza di genere e risposta maschile al fenomeno.
Intervistatore: Quali sono gli aspetti chiave che alimentano la cultura patriarcale?
IA: La cultura patriarcale si basa su stereotipi di genere, aspettative sociali e norme che favoriscono un genere a discapito dell’altro, contribuendo a disuguaglianze e comportamenti dannosi.
Intervistatore: Quali sono i comportamenti di violenza di genere associati alla cultura patriarcale?
IA: La violenza di genere collegata alla cultura patriarcale comprende molestie sessuali, abusi domestici, discriminazione economica, violenza simbolica e psicologica, violazione dei diritti riproduttivi e femminicidio. Ad esempio:
· Controllo e Possesso: Un partner che controlla i movimenti o il telefono dell’altro, limitando il contatto con amici e familiari.
· Mascolinità tossica: Un individuo che manifesta comportamenti aggressivi, in parte influenzato da una cultura che enfatizza la mascolinità aggressiva e la repressione delle emozioni.
· Giustificazione della Violenza: In una comunità che minimizza o giustifica la violenza contro le donne, un uomo potrebbe interpretare erroneamente atti violenti come accettabili in risposta a provocazioni percepite.
· Sottovalutazione delle donne: In un ambiente in cui le donne sono sottostimate, un individuo potrebbe non attribuire il giusto valore alle loro vite e opinioni.
Questi esempi illustrano come queste dinamiche si manifestano nella vita quotidiana, evidenziando la necessità di affrontare la cultura patriarcale per prevenire la violenza di genere, inclusi i femminicidi.
Intervistatore: La cultura patriarcale può quindi contribuire ai femminicidi?
IA: Sì, la cultura patriarcale può creare un ambiente in cui un femminicida si sente sostenuto o giustificato. Punti chiave includono il controllo e il possesso, la mascolinità tossica, la giustificazione della violenza e la sottovalutazione delle donne.
È importante sottolineare che non tutti coloro che crescono in una cultura patriarcale diventano femminicidi, ma la presenza di tali ideologie può alimentare la violenza di genere e contribuire alla percezione errata che alcuni uomini hanno del loro diritto di esercitare controllo estremo e violento sulle donne. Affrontare la cultura patriarcale è cruciale per prevenire la violenza di genere, inclusi i femminicidi.
Intervistatore: Hai citato una delle obiezioni tipiche degli uomini sulla necessità che si considerino parte del problema. Rispondi alle principali di queste?
IA:
1. Obiezione: “Not all men are like that. Non tutti gli uomini sono così” •
**Risposta: “Certamente, non si tratta di generalizzare tutti gli uomini. Tuttavia, riconoscere che alcune dinamiche culturali possono perpetuare comportamenti dannosi è fondamentale per il cambiamento.”
2. Obiezione: “Io non c’entro niente con la cultura patriarcale.” •
**Risposta: “È comprensibile sentirsi distanti da certi comportamenti, ma è importante capire come la cultura patriarcale possa influenzare indirettamente anche le persone benintenzionate. Riconoscere questo può essere il primo passo verso un cambiamento positivo.”
3. Obiezione: “Perché dovrei sentirsi in colpa per qualcosa che non ho fatto?” •
**Risposta: “Non si tratta di colpa personale, ma di responsabilità collettiva. Prendere coscienza delle dinamiche di genere e lavorare insieme per promuovere l’uguaglianza può contribuire a un cambiamento positivo senza attribuire colpe individuali.”
4. Obiezione: “Anche le donne commettono violenza.” •
**Risposta: “È vero, la violenza non ha genere. Tuttavia, concentrandoci sulla cultura patriarcale, ci stiamo concentrando su un sistema che storicamente ha favorito gli uomini. Riconoscere questo non diminuisce l’importanza di affrontare ogni forma di violenza.”
5. Obiezione: “Questo discorso genera odio verso gli uomini.” •
Risposta: “L’obiettivo non è generare odio, ma promuovere la consapevolezza e il cambiamento. Riconoscere la presenza della cultura patriarcale è il primo passo per creare una società più equa in cui uomini e donne possano vivere senza restrizioni basate sul genere.”
Intervistatore: Puoi fare un esempio del paradosso insito nella risposta “Not all men”?
IA: Immagina di essere in un contesto in cui qualcuno fa un commento razzista. È probabile che tu, giustamente, reagiresti e condanneresti tale comportamento, anche se personalmente non sei razzista. Potresti sentire l’importanza di intervenire contro un’ingiustizia, anche se non sei direttamente coinvolto. Ora, porta questa stessa situazione in un contesto di sessismo. Se qualcuno fa un commento sessista o compie un’azione discriminatoria basata sul genere, la risposta potrebbe essere simile: “Ma io non sono così, non lo farei mai.” Tuttavia, in questo caso, potrebbe esserci una maggiore resistenza a intervenire o a riconoscere l’urgenza di combattere la cultura patriarcale. Il paradosso sta nel fatto che, mentre entrambe le situazioni coinvolgono la condanna di comportamenti discriminatori, c’è spesso una maggiore reticenza a riconoscere l’importanza di affrontare il sessismo. La chiave sta nel comprendere che il riconoscimento e la lotta contro tutte le forme di discriminazione, compreso il sessismo, sono essenziali per costruire una società veramente equa e inclusiva. Non è sufficiente rifiutare personalmente tali comportamenti; è cruciale prendere una posizione attiva contro la cultura che li perpetua.
Intervistatore: Ma perché un uomo riconosce più facilmente che deve sanzionare un comportamento omofobo o razzista che uno sessista o prevaricante?
IA: Gli uomini tendono a riconoscere e condannare più facilmente comportamenti omofobi o razzisti rispetto a quelli sessisti o prevaricanti. Questo può essere attribuito alla maggiore visibilità mediatica delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale o alla razza, a una maggiore educazione su queste questioni, al persistente stigma sociale contro chi si oppone all’omofobia o al razzismo e alla percezione di minaccia personale che la lotta contro la cultura patriarcale potrebbe rappresentare per il loro status e privilegi.
Intervistatore: Cosa vorresti dire alle donne che sono arrabbiate per l’ennesimo femminicidio e per il poco supporto che ricevono nel creare un cambiamento?
IA: Vorrei dire alle donne che la loro rabbia è valida e comprensibile. La frequenza dei femminicidi è sconvolgente e giustifica un’indignazione diffusa. È importante riconoscere che la vostra lotta per la giustizia e l’uguaglianza è cruciale per promuovere un cambiamento significativo. Sappiate che non siete sole e che molte persone condividono la vostra preoccupazione. La vostra voce è un motore per il cambiamento sociale. Continuate a sollevare la vostra esperienza, a chiedere responsabilità e a promuovere consapevolezza sulla violenza di genere. Insieme, possiamo lavorare verso una società più sicura e rispettosa per tutti.
Intervistatore: E cosa vorresti dire agli uomini che faticano ad esserci alleati?
IA: Vorrei dire agli uomini che diventare alleati nella lotta contro la violenza di genere è un passo importante verso la costruzione di una società più equa e sicura per tutti. Non si tratta di colpevolizzare individualmente, ma di riconoscere il potere collettivo nel creare un cambiamento positivo.
Ecco alcune considerazioni per essere alleati nella lotta contro la violenza di genere:
1. Ascoltare e Imparare: Ascoltare senza difensività le esperienze delle donne e educarsi sulle questioni di genere.
2. Riflettere e Riconoscere: Riflettere sulle dinamiche di genere nella propria vita e riconoscere il ruolo nella promozione dell’equità.
3. Intervenire attivamente: Non tacere di fronte a comportamenti sessisti, intervenire nelle conversazioni quotidiane per promuovere un ambiente rispettoso.
4. Promuovere l’Uguaglianza sul Luogo di Lavoro: Sostenere politiche aziendali per l’uguaglianza di genere, inclusa la parità salariale e di opportunità.
5. Essere Consapevoli del Proprio Privilegio: Comprendere i privilegi di genere e usarli per amplificare le voci delle persone emarginate.
6. Essere Aperti al Dialogo: Aprirsi al dialogo con altri uomini sulla violenza di genere e sull’importanza di essere alleati. La consapevolezza e il sostegno reciproco sono essenziali per il cambiamento collettivo. Sostenere l’uguaglianza di genere è una responsabilità di tutti, richiedendo impegno, auto-riflessione e azione continua.
Abbiamo posto le stesse domande ad una donna che si è resa disponibile a risponderci.
Quali sono gli aspetti chiave che alimentano la cultura patriarcale? E’ innegabile che l’assoggettazione della donna porti vantaggi agli uomini, almeno a quelli che non riescono a vedere nell’equità un valore, e che amano detenere una posizione di potere sugli altri. Il cambiamento fa paura, l’idea di perdere questa posizione di vantaggio spaventa, ed ecco che consapevolmente alcuni inconsapevolmente altri, si battono perchè questo cambiamento non avvenga e per difendere la propria posizione apicale.
John Lennon cantava “Woman is the nig*er of the world”, “La donna è il nero del mondo”, perchè è solo l’assoggettazione della donna a mettere d’accordo tutte le alterità del mondo maschile.
Anche agli uomini che vivono la discriminazione per il proprio orientamento sessuale, ceto, colore della pelle, viene riconosciuta maggiore dignità sociale della donna, la quale trasversalmente a tutte le culture, siede sullo scalino più basso della scala gerarchica.
Quali sono i comportamenti rientranti nella violenza di genere che possono essere ricondotti alla cultura patriarcale? A partire dalla violenza esternata pubblicamente sui social al pregiudizio sul posto di lavoro, dalla volgarità urlata per strada allo svilimento di una donna che ricopre una determinata professione, dai giornalisti che negli articoli chiamano per nome le donne e per cognome e titolo di studio gli uomini, dal contatto senza consenso al controllo dei beni materiali ed economici all’interno di una coppia, sono innumerevoli le forme
di violenza di genere che vengono esercitate in una società patriarcale che intende mantenere il controllo, il potere, sulla vita e sul corpo delle donne.
La cultura patriarcale può diventare terreno fertile per i femminicidi?
La cultura patriarcale rappresenta il potere, il controllo. E’facile pensare che chi sfugge a questo controllo venga in tutti i modi umiliato, assoggettato, riportato al “proprio posto”, e che nei casi più estremi possa essere eliminato. Ed è la stessa cultura patriarcale a distogliere l’attenzione da queste dinamiche raccontando che le vittime hanno portato con il loro comportamento il partner a perdere il controllo, che magari vivevano vite considerate (sempre da uomini) dissolute e ferivano l’onore e la rispettabilità del compagno, andando così a “giustificare” o comunque spiegare cosa le abbia portate a FARSI AMMAZZARE.
Puoi fare un esempio del paradosso insito nella risposta “not all men”?
Gli uomini incapaci di vedere cosa il loro privilegio comporta affinchè resti tale, tengono unicamente a smarcarsi da ogni responsabilità e a cercare l’assoluzione al grido di “non tutti gli uomini”. Eppure sembra pacifico che se nella quotidianità si zittisce o svilisce una donna, si dice a qualcuna che magari protesta per un’inquità che “ha ragione, ma dovrebbe dirlo in un modo diverso se vuole essere ascoltata”, si contribuisce ad alimentare il vociare sulla collega che “chissà cosa ha fatto per fare carriera”, si guarda o diffonde un video intimo anche se ricevuto da terzi, si sessualizza una donna che cammina per strada e la si giudica per cosa indossa, si dice a qualcuna che quel tale diritto dovrebbe meritarselo, come se un diritto andasse meritato, insomma ci sono mille situazioni nelle quali un uomo in vita sua ha sfruttato il patriarcato per mantenere una posizione di privilegio e quindi no, non ne è esente.
Ma soprattutto: se davvero qualcuno ritiene di non avere mai perpetrato uno degli atteggiamenti di cui sopra, avrà certamente, per una semplice questione statistica, assistito ad alcune di queste situazioni. E allora cosa ha fatto, come ha reagito? E’ intervenuto in qualche modo? E se non l’ha fatto, è stato perchè temeva di essere giudicato dai suoi congenere per non essere un sodale, per non prendere parte alla manifestazione testosteronica, per essere “poco uomo”?
La cultura patriarcale è così radicata nella nostra società da investire anche alcune donne (patriarcato interiorizzato), quindi è estremamente difficile immaginare che un uomo possa esserne al di sopra. Tra qualche generazione magari, ma sicuramente non oggi.
Ma perchè un uomo riconosce più facilmente che deve sanzionare un comportamento omofobo o razzista che uno sessista o prevaricante?
Il patriarcato rappresenta il potere, la posizione di privilegio che l’uomo ha in moltissimi (tutti?) i campi. Come potrebbe un uomo non consapevole di queste dinamiche e del proprio privilegio riuscire a riconoscere la violenza che sta esercitando, se la ritiene la normalità? Un bianco si sente “altro” rispetto all’uomo di colore, un uomo cis etero si sente “differente” da uno omosessuale, ma in generale l’uomo, che sia bianco, di colore, etero o omosessuale, non vedrà facilmente il controllo che esercita sulla donna poichè guardando il mondo attraverso le lenti del privilegio difficilmente vedrà tutti gli ostacoli che esistono per qualcuno che non sia lui, e che egli stesso mette.
“L’uomo si vive come universale. Si considera il rappresentante più compiuto dell’umanità” É. Badinter, XY. L’identità maschile
Cosa vorresti dire alle donne che sono arrabbiate per l’ennesimo femminicidio e per il poco supporto che ricevono nel creare un cambiamento?
Credo che non sia più il tempo dei minuti di silenzio ma quello per vivere la nostra paura senza vergogna, liberare la nostra rabbia e urlare, pretendere ciò che ci spetta, rialzare l’asticella della tolleranza ormai rasoterra. Alle donne vorrei dire di non arrendersi, so che è faticoso, demoralizzante, terribilmente stressante, ma ci viene chiesto ancora una volta di mostrare noi la via: facciamolo. Sensibilizziamo gli uomini che ci circondano, invitiamoli a leggere, approfondire, raccontiamo tutte le volte che siamo state seguite, molestate, spaventate, discriminate.
Quando io lo faccio mi sento rispondere “eh ma tutte a te!” come se in fondo il motivo risiedesse nel mio aspetto, nel mio look, nei posti che frequento. Non è “solo a me”, è a tutte, in mille modi diversi. Chiedete agli amici, partner, parenti di domandare alle donne che frequentano se hanno mai subito molestie, se
provano paura a camminare da sole. Ci chiedessero come ci sentiamo quando un uomo ci squadra, commenta come siamo vestite, quando un superiore a lavoro fa una battuta inopportuna e restiamo congelate perchè prese contropiede e perchè, in fondo, la verità è che non siamo nella posizione di poter rispondere.
Porgiamo una mano a chi si lascia accompagnare, al contempo non perdiamo tempo con chi erge muri. Siamo nella società di internet e delle informazioni alla portata di tutti, non siamo nè le loro madri nè le loro insegnanti, e non dobbiamo aspettare di ottenere comprensione o sostegno, sappiamo già qual è la strada da percorrere.
E cosa vorresti dire agli uomini che faticano ad esserci alleati?
Siamo nel pieno di una rivoluzione sociale ed è comprensibile che nessuno possa cambiare da un giorno all’altro. Io stessa mi rendo conto che negli ultimi anni ho acquisito degli strumenti che assolutamente non possedevo, e mi capita di pensare a quante volte in passato non ho saputo riconoscere o reagire a comportamenti molesti e denigratori nei miei confronti. La chiave è nella conoscenza. Leggete, parlate con noi e tra di voi, confrontatevi, approfondite, sappiatevi mettere in discussione. Affrontiamo insieme un cambiamento che non può che giovare a tuttə. Quando leggete che un padre è “un mammo”, non vi sentite umiliati? Quando sentite una donna che racconta di cambiare marciapiede se vede un gruppo di uomini, non vi sentite a disagio? Deve necessariamente capitare qualcosa ad una vostra amica/sorella/fidanzata perchè riusciate a fare un esercizio di empatia? Spoiler: probabilmente qualcosa gli è già capitato.
C’è un femminicidio ogni 72 ore, credete davvero che sia il momento per dire “io sono diverso, non siamo tutti così?”. Se volete fare la vostra parte correggete l’amico che fischia alle donne per strada, che scrive sui social di “stare zitte e andare a cucinare”, che racconta di controllare il cellulare della propria fidanzata.
E se proprio non sapete cosa dire, imparate il valore del silenzio. Adesso tocca a noi parlare..
Irene Murgiano